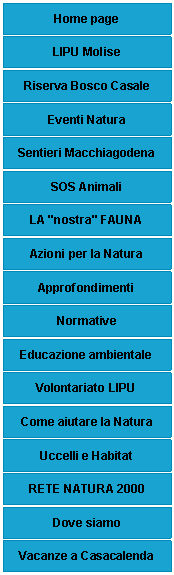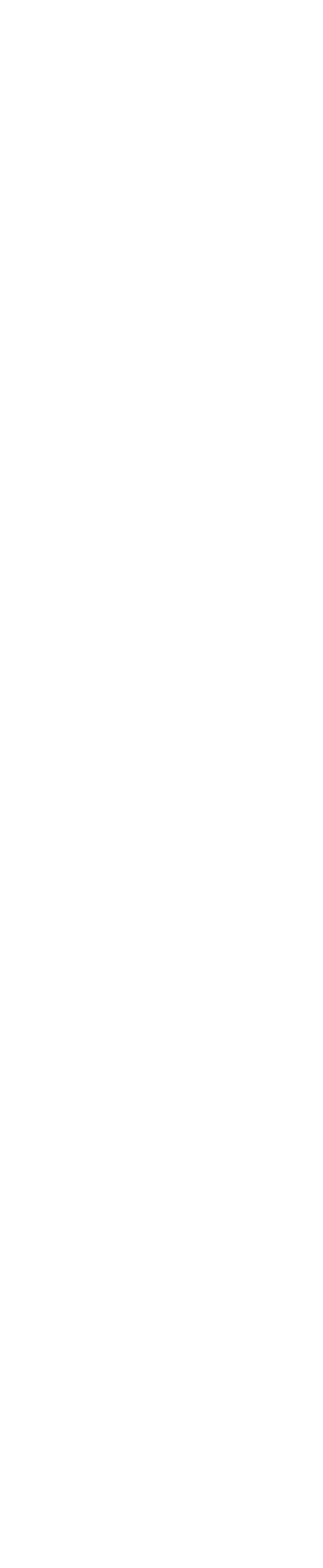
|
Biomasse: sono davvero una fonte energetica e rinnovabile? |
|
Innanzitutto definiamo cosa sono le Biomasse: Biomassa è un termine che riunisce una gran quantità di materiali, di natura estremamente eterogenea. Con alcune eccezioni, si può dire che è biomassa tutto ciò che ha matrice organica. Sono da escludere le plastiche e i materiali fossili che, pur rientrando nella chimica del carbonio, non hanno nulla a che vedere con quei materiali organici che si riproducono naturalmente in modo ciclico (rinnovabili). Le biomasse possono essere costituite dai residui delle coltivazioni destinate all’alimentazione umana o animale, da piante espressamente coltivate per scopi energetici (produzione di biodisel o alcol), da residui forestali, da scarti di attività industriali (come i trucioli di legno), da scarti delle aziende zootecniche o dalla parte organica dei rifiuti urbani. Le biomasse utilizzabili a fini energetici (come biocarburanti, biocombustibili per la produzione di energia elettrica, biogas dalla digestione) per essere considerate fonti energetiche rinnovabili (FER), a differenza delle altre FER (eolico, solare, idroelettrico, ecc.) che lo sono di per se (per natura), devono soddisfare determinate caratteristiche di ecosostenibilità nella loro produzione e utilizzo. Le filiere agroenergetiche da promuovere in quanto, oltre che rinnovabili siano anche ecosostenibili: ♣ devono essere corte (nello spazio) e brevi (nel tempo); ♣ devono garantire un bilancio energetico positivo e una produzione complessiva di CO2 negativo o nullo; ♣ non devono prescindere dal contributo che le buone pratiche agricole possono dare alla fissazione al suolo del carbonio, alla lotta alla desertificazione e all’erosione, al processo di graduale sostituzione dei concimi chimici e al miglioramento della qualità dei suoli, mediante, ad esempio, l’uso in agricoltura di ammendanti prodotti dal compostaggio delle biomasse ad elevata umidità. Ma non essendoci al momento regolamentazione normativa (direttive, circolari o quant’altro) da assumere a riferimento, che ne stabiliscano obbligatoriamente queste caratteristiche, si pone, per chi si trova a programmare o a valutare e approvare determinati progetti che prevedono il loro sfruttamento, il problema di come considerare questi criteri di ecosostenibilità. Criteri che rappresentano, come già detto, una sorta di spartiacque per la classificabilità delle biomasse fra le FER. Le biomasse sono da considerarsi una fonte rinnovabile? E come incidono sui cambiamenti climatici (produzione di CO2)? Le biomasse vanno considerate rinnovabili se quanto viene sottratto all’ambiente naturale o agricolo corrisponde a quanto nuovamente sarà riprodotto: in un anno è possibile togliere all’ambiente tanti quintali di biomassa, quanti in quell’anno l’ambiente riprodurrà o naturalmente o artificialmente (coltivazioni agricole dedicate o riforestazione). Per il bilancio della CO2 teoricamente, se tanti sono i quintali che si bruciano quanti quelli che si riproducono annualmente, la CO2 prodotta dalla combustione sarà circa uguale a quella inglobata dalle piante, grazie alla fotosintesi. Tuttavia, se consideriamo che le coltivazioni (erbacee o arboree) richiedono l’impiego di fertilizzanti chimici di sintesi e fitofarmaci, oltre a macchine agricole, pompe per l’irrigazione e trasporto dei prodotti, ciò significa che sono necessarie grandi quantità di energia di origine fossile che produce CO2. Pertanto il bilancio non è più in equilibrio, perché vi è una produzione netta di CO2 a causa dell’impiego di energia fossile, non rinnovabile: le biomasse utilizzabili devono dunque essere o naturali o prodotte biologicamente o “secondo natura”. L’industrializzazione dell’agricoltura ha aumentato in media di 50 volte il flusso di energia rispetto all’agricoltura tradizionale. Pertanto, per esempio, il sistema agricolo statunitense consuma dieci volte più energia di quanta ne produca sotto forma di cibo o, se si vuole, utilizza più energia fossile di quella che deriva dalla radiazione solare. Considerando solo la produzione dei fertilizzanti, va detto che servono circa due tonnellate di petrolio (in energia) per produrre e spargere una tonnellata di concime azotato. L’utilizzo a fini energetici delle biomasse è consentito a condizione che siano rispettati i criteri di efficienza energetica. Bisogna calcolare in modo completo il contributo delle diverse fonti di energia che concorrono al processo produttivo (input), dalla coltivazione al consumo finale (ad esempio carburanti per trasporti, fertilizzanti, energia elettrica, manodopera …) e la quantità di energia che se ne ricava (output). Bilancio energetico positivo e produzione di CO2 negativa Il valore positivo del rapporto output/input si ha quando l’energia solare immagazzinata e poi liberata (output) è maggiore di quella proveniente da fonti non rinnovabili utilizzata lungo tutto il processo produttivo (input). Se il saldo energetico è positivo dovrebbe essere pari o negativo quello della produzione di CO2; ma qui entra in gioco la variabile tempo. L’anidride carbonica fissata nei combustibili fossili in processi durati milioni di anni, viene liberata in atmosfera nello spazio brevissimo della combustione degli stessi. È questo che ne provoca l’accumulo in atmosfera e causa l’effetto serra. La CO2 prodotta nella conversione di biomasse viene utilizzata nel processo di fotosintesi per la produzione di nuova biomassa e non contribuisce agli effetti negativi sul clima. È chiaro però che la conversione della biomassa in energia deve essere compatibile con i ritmi naturali, e il tempo dalla coltivazione al consumo finale deve essere il più breve possibile: ad esempio un conto è produrre biodisel o bioetanolo proveniente da una coltura che ha bisogno di soli pochi mesi di coltivazione, tutt’altro conto è trasformare foreste centenarie – quindi con cento anni di CO2 fissata – in legna da ardere. Di qui il concetto di ciclo breve nel tempo. Ciclo corto (nello spazio) e breve Nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili derivate da processi produttivi agricoli è necessario fare una precisa distinzione fra le produzioni espressione dei filiere produttive locali e le produzioni energetiche rinnovabili con biomasse o concentrati di esse con provenienza estera. Pur essendo ambedue no fossil – e quindi con emissioni di CO2 pari a zero – non si può riconoscere agli impianti bioenergetici che si approvvigionano all’estero la stessa valenza ambientale delle produzioni locali. E questo per due motivi: ♣ il primo, di carattere strettamente ambientale, è che i già risicati argini del bilancio energetico vengono fortemente ridotti o azzerati con i trasporti; ♣ il secondo, non meno importante, è di carattere etico: questi processi intensificano la rapina delle risorse agricole del sud del mondo e sottraggono alle produzioni alimentari enormi quantità di terreno in aree dove fame e sottonutrizione sono ancora presenti. Circoscrivere il raggio in cui reperire la biomassa necessaria all’alimentazione dell’impianto, ha lo scopo di rendere la biomassa a tutti gli effetti una fonte energetica rinnovabile e sostenibile. E’ di facile comprensione infatti, che il beneficio dovuto al bilancio nullo di emissioni di CO2 della biomassa ad uso energetico può essere vanificato dall’apporto delle emissioni di CO2 generate dal trasporto della biomassa fino all’impianto, in maniera più o meno significativa a seconda della distanza di origine delle biomasse medesime e del combustibile usato per il trasporto. Le garanzie tra gli attori della filiera Le filiere agroenergetiche devono fondarsi sulla figura dell’agricoltore che non può essere solo un attore tra i tanti, e cioè l’anello iniziale (e debole) della lunga catena che porterà alla produzione di energia, ma deve essere un protagonista di tutta la filiera, anche sotto il punto di vista dei redditi garantiti dalla riconversione energetica delle sue colture. Le colture bioenergetiche non hanno un mercato diffuso in grado di sostenere iniziative imprenditoriali slegate da un preciso e organizzato processo e flusso di filiera. Come tutte le colture destinate alla trasformazione industriale devono essere contrattualizzate con appositi accordi interprofessionali. In particolare gli impianti di combustione devono essere vincolati ad un preciso e dimostrabile accordo di filiera locale con i produttori. Senza di ciò la nascita di un impianto di generazione o di cogenerazione finirà per essere utilizzato per bruciare biomasse prodotta altrove, vanificando tutti i benefici ambientali in termini di emissioni complessive di gas di serra derivanti dal loro uso energetico. Va infine esclusa categoricamente l’ipotesi di utilizzare gli impianti a biomasse per bruciare anche i rifiuti di matrice organica, molto più utili per la produzione di compost per l’agricoltura per compensare la tendenza alla desertificazione dei suoli. Faccio ora un esempio sul calcolo delle superfici occorrenti per il mantenimento di un impianto a biogas (al momento la modalità di utilizzo della biomassa probabilmente più efficiente e meno impattante) da 1,4 MW, e conseguentemente sulla necessità di “bacinizzare” il territorio al fine di prevedere una giusta quantità di impianti sostenibili dal territorio stesso. Atteso che la produzione di biomassa complessiva, necessaria per alimentare in un anno tale impianto è pari a 30.000 ton. di insilati di cereali, si ritiene che per quanto riguarda la produzione di insilati di mais si dovrebbe calcolare la resa unitaria non tanto sui 690 q.li ad ettaro, ottenibili solo con il ricorso alla pratica irrigua così come proposto dal richiedente, ma in coltura asciutta. Questo in quanto da un punto di vista della sostenibilità ambientale la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere perseguita utilizzando o i sottoprodotti/scarti delle produzioni agricole o nel caso di coltivazioni dedicate, apportando i minori “inputs” energetici possibili. Pertanto calcolando una produzione media di 550 q.li/ha di insilati in coltura asciutta il fabbisogno complessivo di terreni per garantire le 30.000 ton necessarie all’anno sono stimabili in 545 ettari anziché i 430 ettari come indicato in alcuni casi pratici. Inoltre, dovendo l’azienda che intende realizzare l’impianto garantire almeno il 50,1% di produzione propria, la superficie minima che annualmente tale azienda dovrà investire, per ottenere la materia prima occorrente, non potrà essere inferiore a 275 ettari. Superficie questa che dovrà inoltre essere accompagnata da un minimo di rotazione dei terreni al fine di evitare problemi di natura agronomica (stanchezza dei terreni, rese, apporti di inputs chimici ecc.); la rotazione dovrà essere effettuata alternando la stessa coltura sullo stesso terreno ogni tre anni e questo pertanto comporta la disponibilità, sempre in capo all’azienda stessa di una superficie di almeno 825 ettari. A questo si aggiungono le necessarie considerazioni in merito all’area di reperimento delle biomasse, ipotizzando che essa non possa essere superiore ad una superficie di raggio 25Km circa (vedi alcuni piani energetici provinciali che hanno trattato la materia) al fine di garantire il principio delle filiere corte nello spazio. È evidente quindi come non sia possibile pensare di localizzare ovunque sul territorio impianti energetici a biomassa a prescindere dalla effettiva disponibilità in loco della biomassa stessa. Sui territori agiscono contemporaneamente diverse competenze che non dialogano assolutamente fra di loro: accordi nazionali che riguardano il futuro degli ex zuccherifici, piani energetici regionali con previsioni, p.e. quello della Regione Emilia-Romagna, di impianti a biomassa da 300 MW, competenze provinciali per impianti di taglia inferiore: nessuno che si occupi di valutare la disponibilità effettiva della biomassa tenendo conto anche della necessità di garantire coltivazioni per l’alimentazione. Conseguentemente non è possibile, per tutte le argomentazioni fin qui svolte circa la sostenibilità ambientale, localizzare comunque impianti alimentati da biomassa proveniente da altri Paesi: insilato di mais dall’Argentina o olio di palma dal Madagascar o da altrove. In conclusione, lo sviluppo di filiere agricole non food a fini energetici, deve attuarsi attraverso la messa a punto di un sistema normativo regolamentare nazionale e/o regionale che assicuri che le produzioni agricole portino reali benefici al bilancio energetico ed ambientale complessivo, mirando ad una effettiva riduzione di CO2, salvaguardando specie ed habitat dalle minacce rappresentate dalla possibile introduzione di colture transgeniche e, ultimo ma non ultimo, la sovranità alimentare delle popolazioni locali. |
|
© Articolo di Gabriele Bollini—Rete Lilliput e Rete di Economia Solidale—Pubblicato su periodico “La Fonte” |

|
Per gli uccelli, per la natura, per la gente |
|
Il sito della LIPU del Molise |